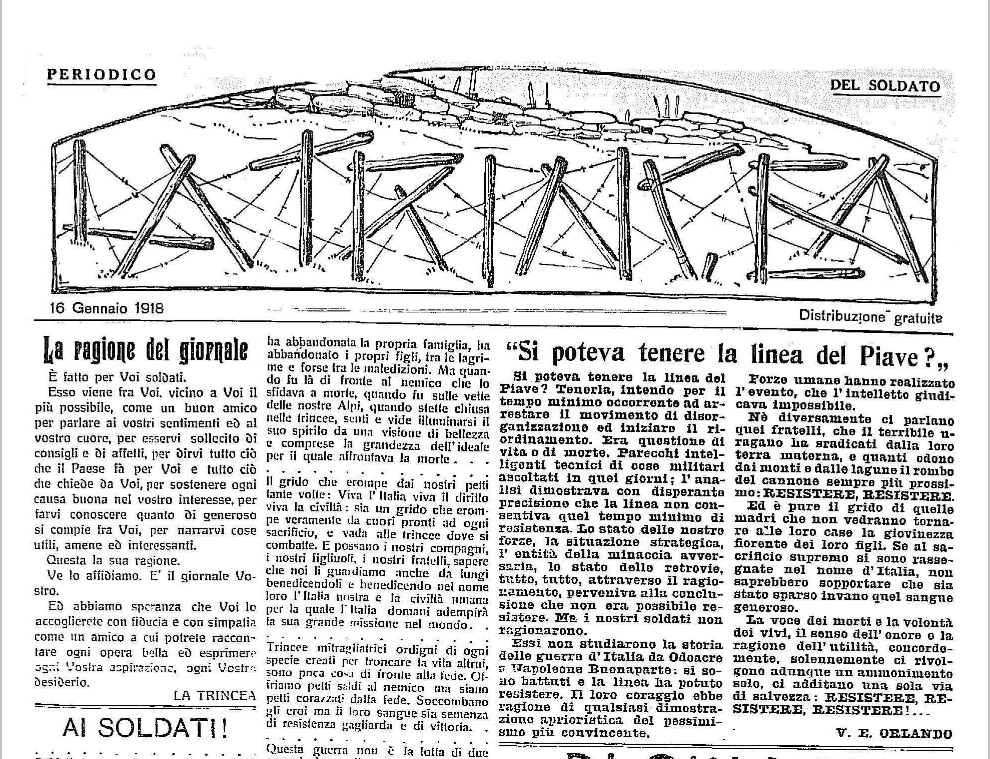Di Luca Villani, partner di The Van
Quando il generale Armando Diaz è subentrato a Luigi Cadorna dopo la disfatta di Caporetto ha dovuto ricostruire, oltre al morale di una nazione intera, l’esercito italiano, cioè un’azienda da qualche milione di persone. Il paragone con l’azienda non è certo inedito: Diaz, che è stato studiato anche per le sue doti manageriali, dedicò da subito molta attenzione ai suoi “dipendenti”, migliorando non solo gli armamenti, ma anche l’alimentazione e i benefit (come ad esempio le polizze assicurative). E la comunicazione.
Una delle iniziative più interessanti fu infatti l’impulso dato ai cosiddetti giornali di trincea, che nascevano spontaneamente, dal basso, all’interno dei reparti militari: servivano a informare, a intrattenere, entro certi limiti anche a ironizzare. Diaz sostenne quelli che esistevano e ne fece nascere di nuovi. In pratica, una modernissima operazione di comunicazione interna, al confine con l’“employee advocacy”, ovvero il coinvolgimento dei dipendenti nella reputazione aziendale.
“Non è il momento”
Ma non basta. Una tale attenzione alla comunicazione non solo appare visionaria anche con gli occhi di oggi, ma per di più fu messa in campo in un momento drammatico, nel quale sarebbe stato facile sostenere che le priorità fossero altre: treni, cannoni, divise, cibo. Diaz capì che pur nell’emergenza – anzi, proprio a causa dell’emergenza – le misure organizzative che era chiamato a varare non sarebbero state altrettanto efficaci se non ci fosse stata una chiara condivisione con i suoi uomini. Quindi fece partire la comunicazione insieme alle attività – diciamo così – industriali. Accompagnando i fenomeni, condividendoli e in qualche modo – dove possibile – co-progettandoli. E mostrando così una lucidità maggiore di quelle aziende che sì, sanno di dover comunicare, “ma non adesso”. “Adesso” c’è la fusione, la quotazione, l’acquisizione, il rebranding, il piano industriale, il nuovo Ceo. “Dopo” ci sarà tutto il tempo per comunicare.
Il “dopo” non esiste
Negli ultimi anni abbiamo, tutti, dovuto ammettere che aveva ragione Eraclito quando scriveva che “niente è costante come il cambiamento” e che quel dopo calmo, stabile, ideale non esiste. Se ci ostiniamo ad aspettarlo, quel “dopo”, ci troveremo sempre fuori tempo massimo. A smuovere le acque è stata la pandemia: come il fronte italiano a Caporetto, le aziende si sono rotte. Si è rotta, in particolare, la centralità del luogo di lavoro che, permettendo di incontrarsi quotidianamente, forniva la sensazione che in fondo tutti sapessero tutto. Oggi ci sono (cito casi reali) persone assunte durante la pandemia che non conoscono i loro colleghi; aziende che hanno fatto una fusione durante la pandemia in cui nessuno ha mai visto gli “altri”; persone in smart working (ma sarà davvero smart, un lavoro che produce questi effetti?) da due anni che, temendo cattive notizie, non aprono più le e-mail provenienti dalla direzione HR.
La tentazione del “dopo”, insomma, non è scomparsa. Ma in questo nuovo scenario molte aziende hanno capito che bisogna comunicare adesso, subito. C‘è una grande minaccia (che le persone smarriscano completamente il senso del loro lavoro), ma anche una grande opportunità: le ricerche e l’osservazione empirica dimostrano che, malgrado tutto, la fiducia nelle imprese è ancora forte e, anzi, si estende dai temi strettamente lavorativi a quelli sociali (l’inclusione, il cambiamento climatico, il welfare). C’è, insomma, una trincea da difendere: quella del senso del lavoro, del suo significato ultimo, dell’azienda intesa anche come una comunità che condivide alcuni valori, specie adesso che il lavoro è diventato ibrido. Come Armando Diaz, possiamo difenderla anche con la forza dei pensieri, delle idee, delle immagini. Ma adesso, non dopo.
Questo articolo è apparso, in una versione leggermente diversa, sull’ultimo numero di Direzione del Personale, il magazine di AIDP.